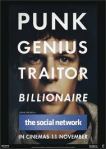1. Where have all the writers gone?
 In Sotto gli occhi di tutti (2004), Valerio Evangelisti formula alcune riflessioni assai critiche sugli intellettuali e scrittori italiani a lui contemporanei:
In Sotto gli occhi di tutti (2004), Valerio Evangelisti formula alcune riflessioni assai critiche sugli intellettuali e scrittori italiani a lui contemporanei:
Ma sbaglia chi crede che, a fronte di questo vuoto [NDR quello della politica berlusconiana], gli intellettuali non allineati al potere svolgano davvero la funzione antagonistica di loro pertinenza. Molti di loro denunciano le ripetute violazioni della legalità, ma non le connettono né al segno di classe del governo Berlusconi, espressione di una nuova borghesia arricchitasi con il commercio, i servizi, le comunicazioni, le speculazioni di borsa, né a un quadro internazionale posto sotto il segno dell’imperialismo e del neocolonialismo. Mancano in Italia i Bordieu, le Forrestier, le Susan George, i Gore Vidal. Se protesta c’è, è contingente e partitica. (Evangelisti, p. 22).
Dopo aver tracciato un quadro apocalittico degli anni 2001-2004, Evangelisti continua col suo affondo: “A parte qualche autore di genere, ignorato in quanto tale dall’accademia, nessuno si chiede se l’ideologia neoliberale, fatta propria dal centrosinistra, non contenesse in germe la vittoria di berlusconi e del suo governo.” (p. 24) E, per concludere, “Si comprende, allora, il prevalere del minimalismo più oltranzista nella letteratura italiana di oggi: non solo mancanza di idee, ma anche di coraggio.” (p. 24).
La paraletteratura come alternativa alla paraculaggine letteraria, verrebbe da dire.
A quasi tre settimane dall’inizio del #rogodilibri, vinto il primo round (ma non la “guerra”, per cui è importante continuare a mobilitarsi), una cosa emerge più chiara che mai. Almeno un singolo elemento è migliorato dal 2004 ad oggi, in una pur sconfortante italietta: la situazione dell’impegno politico tra i letterati. La funzione degli intellettuali, da questa storiaccia, emerge infatti ben più viva di quanto non ci si potesse aspettare. Anche alla faccia di chi, forse confondendo il panorama delle proprie frequentazioni con la “letteratura” tout court, ancora pochi mesi fa continuava a lamentare un’Italia senza scrittori o un paese morto e privo di intellettualità (a proposito, dove sono in tutta questa storia i critici “militanti” e gli alfieri del “ritorno alla realtà”?). L’Italia non pullulerà di intellettuali, ma ha degli scrittori capaci di attivarsi, non solo nelle forme facili e consumistiche della protesta virtuale (l’attivismo da click, fatto di petizioni e inviti per cause su Facebook), ma nelle piazze, nelle strade e anche sulla rete, usata creativamente e in modo orizzontale. Scrittori che non parlano solo alla loro comunità di lettori, ma cercano di saldare la loro specifica lotta con altri “segmenti” (come si usava dire nel movimentese di vecchio corso) dalle proteste della FIOM a quelle degli studenti. Si discute, ci si scambiano pareri, metodi e forme creative di lotta, senza dimenticare la vecchia modalità, quella da suola&selciato. Sembrerebbe quasi un ritorno al passato; e non lo è, invece.
Nella battaglia sul #rogodilibri, si sono ritrovati alcuni dei filoni più vitali della letteratura italiana, o della riflessione su di essa: il vivace mondo delle riviste on-line e dei blog letterari (carmilla, giap, il primo amore, lipperatura…), il variegato insieme di autori che, nel rinnovamento della letteratura di genere (noir e giallo in primis) hanno colto l’occasione per abbandonare le poetiche ombelicali del minimalismo made in italy e, occorre dirlo, molti degli autori che Wu Ming 1 aveva incluso nel suo Memorandum ormai quasi tre anni fa. Autori spesso tra loro in polemica si trovano dalla stessa parte, in questa occasione (penso ai Wu Ming e a Scarpa, che si sono scontrati su più di una questione, dalla valutazione del caso Saviano alla stessa etichetta di New Italian Epic), mentre anche chi era stato contrario all’appello, o semplicemente non vi aveva aderito (vedi alla voce Pennacchi), ha comunque espresso solidarietà a chi l’aveva firmato.
A leggerla con attenzione, la listaccia di Speranzon e sodali sembrerebbe quasi un nuovo “canone”. Basta leggerli: Valerio Evangelisti, Luigi Bernardi, Christian Raimo, Carla Benedetti, Giuseppe Genna, Marco Philopat, Sandrone Dazieri, Domenico De Simone, Lello Voce, Tiziano Scarpa, Enrico Remmert, Gianfranco Manfredi, Nanni Balestrini, Nicola Baldoni, Cristina Brambilla, Dario Voltolini, Alessandro Bertante, Stefano Tassinari, Giovanni Zucca, Alessandro Mazzina, Giorgio Agamben, Massimo Carlotto, Luca Masali, Rossano Astremo, Ray Luberti, Pino Cacucci, Simone P. Barillari, Loredana Lipperini, Monica Mazzitelli, Biagio M. Catalano, Michele Monina, Mauro Smocovich, Girolamo de Michele, Antonio Moresco, Enzo Fileno Carabba, Vittorio Catani, Gabriella Fuschini, Fausto Giudice, Massimiliano Governi, Giovanni De Caro, Laura Grimaldi, Roberto Saporito, Francesco Cirillo, Tommaso Pincio (Marco Colapietro), Wu Ming…. Non sarà una “nebulosa”, ma c’è aria di famiglia.
Un canone in primo luogo etero-diretto: nel mirino finiscono autori scomodi perché “non” in linea con il “regime”, al di là del loro specifico valore letterario (che comunque non manca, a partire da prestigiosi riconoscimenti come lo Strega, per non parlare del pluri-tradotto e quasi venerato, ovviamente all’estero, Agamben). Ma questa non è solo un’accozzaglia di scrittori messi lì a casaccio dal “regime” per fare la parte del babau. Con misure e forme diverse, molti degli autori hanno espresso posizioni politiche al di fuori del gran bazar critico-mediatico-letterario, anche al di là della questione Battisti. Non solo firmando petizioni e appelli, ma scegliendo di prendere posizione nel loro scrivere (un esempio? Il modo in cui molti autori, da Carlotto a Camilleri, scelsero di inserire, sottocoperta, racconti dei fatti del G8 di Genova nei loro romanzi: un modo per dar testimonianza di una violenta repressione, attraverso i ferri del loro ‘mestiere’). Non chiamiamoli intellettuali. Ma qualcosa in più che scrittori, sì.
Quello che cambia, forse, è la natura non più “individuale”, singola e quindi facile da isolare, della protesta. Allora, che un gruppo di intellettuali sia identificabile – sia pure per pressione esterna, e non per affinità elettiva – è già una questione politica. Questa vitalità, questo impegno, che non è riassumibile nel #rogodilibri, ma è la sintesi di un processo in corso da anni, dovrebbe andare avanti e articolarsi in un discorso. E questo è compito di tutti. Scrittori e lettori; insegnanti e studenti; professionisti della cultura e cittadini che liberamente ne fruiscono.
2. Riscrivere la storia. A Venezia e oltre.
Nel 1567, a un papa Pio V scandalizzato per l’enorme disponibilità di materiale eretico nella troppo tollerante Venezia, il legato Paolo Tiepolo rispondeva che Venezia adoperava, verso gli “eretici”, “più fatti che demostrationi, non fuochi e fiamme, ma far morire secretamente chi merita”. Altro che tolleranza. È però vero che, malgrado lo strapotere gesuitico affermatosi a partire dagli anni ’60 del ‘500 (e culminato nella “liberatoria” espulsione dell’ordine dalla città nel 1657), e malgrado il giro di vite post-tridentino della locale Inquisizione, l’editoria veneziana, soprattutto per la forza del suo capitalismo, rimase una relativa oasi di libertà, continuando a competere con sedi come Ginevra e Lione anche per settori scottanti come la pamphlettistica religiosa o la produzione di Bibbie in volgare. Tutto questo per dire che, quando assessori dal passato più o meno fascista pretendono che Venezia dia il “buon esempio”, diventando la prima città italiana a bandire gli autori “eretici”, sta prendendo piede una grottesca e mostruosa riscrittura della storia.
Non è un caso. La riscrittura della storia è esattamente il terreno su cui si gioca questa partita. È in gioco, più precisamente, la legittimità di una o più ricostruzioni della storia, a fronte di una politica della memoria monolitica e, si potrebbe dire, monologica. Si badi: qui nessuno difende l’opportunità che ognuno “dica la sua”, in una sorta di caricatura del relativismo o del postmoderno applicato alla storia. Ci sono ambiti (per esempio la Shoah) in cui, con tutte le incertezze e le difficoltà del caso, una verità di fondo è stata raggiunta, e pretendere di dirne un’altra è puro e semplice negazionismo. Del resto, anche i fondatori del moderno metodo storico parlano di una storia come ricostruzione, come “lavoro storiografico”; ma Marc Bloch, per relativista che fosse, è morto combattendo contro i nazisti.
Qui si tratta piuttosto di difendere la complessità della storia, il suo essere un portato di variabili e fattori e soggetti distinti, contro una pericolosa idea delle storie monolitiche, storie per “figurine” e per “santini” (attività in cui eccelle la premiata ditta Rai Fiction), o persino di “storie parziali”, da usare come teste di ponte per poi imporre una nuova visione a senso unico (io che sono fascista mi riscrivo la mia storia centrata sui “Ragazzi di Salò” e le do lo stesso valore della storia “ufficiale”, cioè quella scritta dai costituenti e dalla resistenza, due fastidiosi orpelli dei tempi che furono).
Questa preminenza della dimensione “storiografica” è importante per capire quanto accade. Nel caso Battisti, infatti, le posizioni hanno di rado un valore specifico. Quasi mai esse dipendono dal giudizio assunto su questa o quella specifica tesi o affermazione, ma dipendono, invece, dal loro valore simbolico. Così per Umberto Eco, sul blog di Alfabeta 2 dichiara di trovarsi, per una volta, d’accordo con il governo per rivendicare, almeno all’estero, la sovranità e l’autorevolezza di una magistratura sempre più villipesa nei confini nazionali. E così anche molti firmatari dell’appello, per i quali il caso Battisti è l’epitome di una questione più ampia, legata a una ricostruzione a senso unico del passato, fatta di associazioni pavloviane. Una storia che alla parola “terrorismo” accompagna la locuzione “senza se e senza ma” e l’aggettivo “rosso” [Mutatis mutandis, perché i musulmani che si fanno saltare in aria sono “terroristi” mentre il tizio che va a sparare alla Gifford è un cane sciolto, un matto isolato? È una domanda interessante, che qualcuno sulle colonne del Guardian si è posto]. Una lettura di parte della storia, che parla al passato perché le suocere di oggi intendano: una ricostruzione centrata sulla necessità (anch’essa narrativa, in fondo) di un villain, e che non ha nulla a che vedere con la legittima richiesta di verità e giustizia espressa dai familiari delle vittime.
Anche solo per questo, allo scrittore è qui implicitamente riconosciuta una grande responsabilità e un grande valore. Quello di poter scrivere, o se non altro problematizzare, la Storia attraverso il racconto delle proprie storie. Ancora una volta, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.
3. Buoni e cattivi maestri
Dei libri, in questa vicenda, si parla invece molto poco. Nessuno dei censori sembra averli mai letti o sfogliati, evidentemente avendo applicato per primi la censura che propongono di estendere a tutti. Non serve leggerli, i libri: sono libri degli amici di Battisti, satis diximus.
 È chiaramente in gioco il potere simbolico dei libri: un potere che si attua principalmente, a volte esclusivamente, sul paratesto, inclusa la quarta di copertina e il suo enunciato di autorialità. L’autorialità è quella cosa per cui i libri incriminati diventano immediatamente i libri “degli amici di Battisti”, con una semplificazione linguistica degna di Pietro Gambadilegno. Che fa davvero venir voglia di ritirare fuori un certo saggio di Barthes sulla morte dell’autore e distribuirlo, a mo’ di volantino.
È chiaramente in gioco il potere simbolico dei libri: un potere che si attua principalmente, a volte esclusivamente, sul paratesto, inclusa la quarta di copertina e il suo enunciato di autorialità. L’autorialità è quella cosa per cui i libri incriminati diventano immediatamente i libri “degli amici di Battisti”, con una semplificazione linguistica degna di Pietro Gambadilegno. Che fa davvero venir voglia di ritirare fuori un certo saggio di Barthes sulla morte dell’autore e distribuirlo, a mo’ di volantino.
Non ricordo più se nel suo Comment lire les livres qu’on n’a pas lu (traduzione italiana per i tipi della Excelsior 1881, uscita nel 2007), Pierre Bayard si fosse premurato di menzionarla: ma di certo la censura è una forma di non-lettura, che tuttavia non dipende dal pregiudizio selettivo di cui tutti (e specialmente i professionisti della letteratura) ci serviamo per un orientamento preliminare nell’infinità dei possibili percorsi, lo stesso su cui si basa la stessa nozione di “canone”. No, la censura è una non-lettura diversa, una non-lettura preventiva e ‘assimilante’, al ribasso.
Fa impressione vedere che, quasi in contemporanea, copertine o quarte di copertina siano state brandite, nelle piazze da chi le ha dipinte sugli scudi e da chi, temendone il potere, vuole espellerli da tutte le scuole del regno. Il libro agitato comunica, è spauracchio, è sovversione. Del resto, ce lo ricordiamo: Pinocchio finì nei guai per colpa di un libro. L’abbecedario, simbolo del potere: quello che vende per pagarsi l’ingresso al circo, e quello che lo fa diventare assassino all’uscita della scuola, per ribellarsi a un episodio di bullismo ante litteram. Fosse rimasto analfabeta, nessuno gli avrebbe dato fastidio. Anche per comprendere e far comprendere quanto è accaduto in Veneto o nel Trevigiano, si è fatto ricorso a varie figure (le chiamo “figure” e non “metafore”, perché radicate nella storia) imperniate sulla fisicità dei libri: prima tra tutte, quella del rogo nazista, così simile agli autodafé, la pratica che distrusse gran parte dell’universo culturale pre-colombiano, cristianizzato e “de-paganizzato” a forza. E chissà, che dopo l’orgia di metafore ispirate, in alternativa, alla babelica biblioteca di Borges e alla rete (spesso sovrapposte insieme), non si torni finalmente al dominio simbolico del libro “cartaceo”.
È un fatto che la nostra civiltà dello schermo eleva spesso l’oggetto-libro a valore in sé. Così si moltiplicano gli appelli a “leggere”, in nome del potere salvifico della lettura. “Leggere” diventa un imperativo, e, al tempo stesso, un verbo intransitivo. Bisogna “leggere”, indipendentemente da che cosa: Il cacciatore di aquiloni, l’Iliade, Primo Levi e Bridget Jones figurano a pari merito nelle liste della BBC, mentre né Paul Celan né Ben Okri mi pare ne facciano parte (ma correggetemi se sbaglio), e, sempre a proposito di ‘canoni’, pochissimi ricordano che uno dei primi romanzi inglesi, già nel ‘600, era scritto da una donna e aveva per protagonista uno schiavo nero di sangue reale.
A questa esaltazione del potere salvifico e redentore del libro, fa da contraltare la folle censura del libro in nome della sua “pericolosità”. Attenzione: non sono due conformismi diversi, è lo stesso. I libri contagiano e convertono, quasi più in virtù dell’aura magnetica del loro estensore che per il loro specifico discorso (di qui il proliferare di opere, letterarie e filmiche, sulle biografie di grandi scrittori, Jane Austen in testa) : perciò bisogna leggere, o per lo meno comprare e regalare, i “100 libri del secolo” e tenersi alla larga dai “cattivi maestri”. Il ragionamento non fa una grinza.
E questo è il pericolo, quando si gioca solo sul paratesto, sul valore simbolico del libro, sull’aura autoriale. Che lo si faccia da destra (vedi gli innominabili S&D) o persino da sinistra (vedi, nell’ordine il savianismo e, a livello ancora solo potenziale, esclusivamente di rischio, il book bloc). Ché i libri non basta brandirli e agitarli o anche tirarli in testa, bisognerebbe pure aprirli, e leggerli. Molti hanno citato, in questi giorni, Farhenheit 451 come altro esempio di #rogodilibri. Ma la lezione finale del libro è anche una lezione su come si legge: perché Montag, abituato alla lettura distratta, ha letto l’Ecclesiaste in treno e se l’è dimenticato, e dovrà rimuovere tanti strati di nulla per poterlo ricordare, e quindi ripetere ai sopravvissuti del nuovo inverno nucleare. Quella a cui Montag – e noi con lui – deve arrivare, è la lettura come interrogazione critica, come tentativo di costruire un senso anziché di trovarne uno precostituito e con la maiuscola (il “Senso” di ciellina memoria).
 E questo si fa leggendo i libri, non idolatrandone gli autori, fosse pure in virtù del loro coraggio civico. Ho, qui sul mio tavolo, una copia di Burn this book, un’antologia curata da Toni Morrison (Premio Nobel per la Letteratura, per chi ci tiene a saperlo), pubblicata nel 2009 a cura del PEN (chi sono quelli del PEN? Quelli che hanno protestato per un decennio affinché il comunista Dario Fo potesse avere un visto negli USA. Quelli che promuovono campagne per la libertà degli scrittori in tutto il mondo, forse con un orientamento sempre più bipartisan, ma pure con importanti campagne contro le limitazioni alla libertà imposte dal Patriot Act e per il ripristino dell’habeas corpus nella cultura giuridica statunitense post 9/11). La raccolta è interessante, anche se forse un po’ sopravvalutata dai commenti in rete – del resto come si fa a parlare male di un libro che per statuto difende la libertà di espressione? Nell’antologia sono inclusi autori coraggiosi che hanno saputo dar voce a conflitti dimenticati, o a posizioni eretiche a rischio della propria vita, insieme ad autori del mainstream angloamericano, e ad autori che probabilmente sono solo midcult e saranno forse svelati come tali tra un decennio o due (sempre che il mondo non finisca prima). Il libro è profondo e contiene molte verità, ma a fondo non mi convince proprio per questa sua natura meta-letteraria. Alla fine, tra una testimonianza e l’altra, emerge solo il senso di uno “scrivere” necessario e indeclinabile, senza padroni forse, ma anche senza oggetto e senza soggetti.
E questo si fa leggendo i libri, non idolatrandone gli autori, fosse pure in virtù del loro coraggio civico. Ho, qui sul mio tavolo, una copia di Burn this book, un’antologia curata da Toni Morrison (Premio Nobel per la Letteratura, per chi ci tiene a saperlo), pubblicata nel 2009 a cura del PEN (chi sono quelli del PEN? Quelli che hanno protestato per un decennio affinché il comunista Dario Fo potesse avere un visto negli USA. Quelli che promuovono campagne per la libertà degli scrittori in tutto il mondo, forse con un orientamento sempre più bipartisan, ma pure con importanti campagne contro le limitazioni alla libertà imposte dal Patriot Act e per il ripristino dell’habeas corpus nella cultura giuridica statunitense post 9/11). La raccolta è interessante, anche se forse un po’ sopravvalutata dai commenti in rete – del resto come si fa a parlare male di un libro che per statuto difende la libertà di espressione? Nell’antologia sono inclusi autori coraggiosi che hanno saputo dar voce a conflitti dimenticati, o a posizioni eretiche a rischio della propria vita, insieme ad autori del mainstream angloamericano, e ad autori che probabilmente sono solo midcult e saranno forse svelati come tali tra un decennio o due (sempre che il mondo non finisca prima). Il libro è profondo e contiene molte verità, ma a fondo non mi convince proprio per questa sua natura meta-letteraria. Alla fine, tra una testimonianza e l’altra, emerge solo il senso di uno “scrivere” necessario e indeclinabile, senza padroni forse, ma anche senza oggetto e senza soggetti.
Lo scrittore censurato diventa un simbolo, ma è bene che sia, invece, un corpo presente e vivo, con una faccia e una voce e un discorso. Altrimenti si cade nell’estetica del “martirio”, nella retorica della scrittura che è “salvifica” e rivelatrice indipendentemente dal suo contenuto. Una retorica scomoda per l’autore censurato, ma comodissima per il lettore che si auto-assolve leggendone le opere. E finisce che, persi a idolatrare i martiri della verità e gli eroi di carta, ci si dimentichi poi di difenderli quando, silenziosamente, qualcuno li fa sparire dalle biblioteche.
 E’ il torrido luglio bolognese: sudore che scorre a rivoli sul selciato, calore trattenuto dal marmo del Crescentone ed sprigionato, lentamente, nella notte. E’ il 2010, e mi ritrovo con l’amica del cuore in Piazza Maggiore, per assistere alle varie proiezioni gratuite estive. Quella sera danno la “La febbre del fare”, un bel documentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi.
E’ il torrido luglio bolognese: sudore che scorre a rivoli sul selciato, calore trattenuto dal marmo del Crescentone ed sprigionato, lentamente, nella notte. E’ il 2010, e mi ritrovo con l’amica del cuore in Piazza Maggiore, per assistere alle varie proiezioni gratuite estive. Quella sera danno la “La febbre del fare”, un bel documentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi.
 Sempre a proposito di avanguardie, mi colpì molto, nella circostanza quasi simultanea della morte di Alda Merini e Edoardo Sanguineti, una manciata di commenti malevoli riferiti a quest’ultima, e al fatto che le fossero tributati i funerali di stato. C’era chi, dalle pagine dei propri blog invocava l’insufficienza della Merini come paradigma della poesia femminile, e chi coglieva nei funerali di stato alla poetessa (addirittura equiparata a Mike Bongiorno!) la funesta e deprecabile condizione delle patrie lettere – secondo quell’inveterata pratica di chiamare “decadenti” tutte le voci letterarie che esulano dalla propria scuola o dal proprio canone.
Sempre a proposito di avanguardie, mi colpì molto, nella circostanza quasi simultanea della morte di Alda Merini e Edoardo Sanguineti, una manciata di commenti malevoli riferiti a quest’ultima, e al fatto che le fossero tributati i funerali di stato. C’era chi, dalle pagine dei propri blog invocava l’insufficienza della Merini come paradigma della poesia femminile, e chi coglieva nei funerali di stato alla poetessa (addirittura equiparata a Mike Bongiorno!) la funesta e deprecabile condizione delle patrie lettere – secondo quell’inveterata pratica di chiamare “decadenti” tutte le voci letterarie che esulano dalla propria scuola o dal proprio canone. prima di potersi dedicare alla scrittura e alla parola in quanto tali. Ma in questa posizione sta anche una grande forza: che nulla è scontato per una donna che parla e scrive nell’ambiente culturale, e la parola prodotta in queste condizioni è una parola, se non liberata, quantomeno consapevole della propria “posizione”.
prima di potersi dedicare alla scrittura e alla parola in quanto tali. Ma in questa posizione sta anche una grande forza: che nulla è scontato per una donna che parla e scrive nell’ambiente culturale, e la parola prodotta in queste condizioni è una parola, se non liberata, quantomeno consapevole della propria “posizione”.